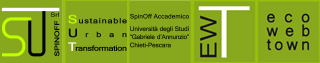Rosario Manzo
Agenzia del Demanio
![]()

Q1. Della utilità del progetto urbano
Le esperienze di questi ultimi anni ci dicono che lo strumento del progetto urbano è sempre meno praticato dalle nostre amministrazioni comunali, soppiantato dal ricorso a singoli interventi, immediatamente cantierabili, non importa se frammentari e slegati da una visione d’insieme della città e del suo futuro. Questo accade soprattutto nelle realtà urbane più complesse, ma in qualche misura si riscontra anche nei centri minori dove tutto dovrebbe essere più facile.
Si tende a sacrificare il valore aggiunto portato dal progetto urbano (comunque inteso, come strategia d’intervento che traguarda le singole azioni anche disgiunte in una prospettiva coerente e condivisa per un’idea di città al futuro) a favore di un empirismo fattuale che induce a preferire la concretezza del presente (le risorse attivabili, gli interessi da soddisfare, i risultati immediatamente tangibili a ristoro degli investimenti fatti) senza interrogarsi sulla effettiva utilità e significatività urbana dei progetti in campo.
In queste condizioni, i progetti urbani sono ancora attuali? Esistono ragioni robuste per sostenerne la utilità, contro le crescenti derive del “presentismo” che producono vari episodi puntuali spesso contraddittori nell’insieme? Oppure dobbiamo rassegnarci alla loro rinuncia?
Per comprendere se ai giorni nostri il “progetto urbano” (PU) abbia o no un’utilità, occorre fare qualche breve premessa. In primo luogo sembra che esista una dimensione soggettiva, non più collettiva e inclusiva, del progetto di trasformazione urbano. Ognuno, oggi, sembra avere un proprio concetto di PU che deriva dalla rielaborazione di una serie di contenuti essenziali rispetto al proprio punto di osservazione: la dimensione dell’intervento (che può ricomprendere un isolato come una parte di città), gli obiettivi (orientati dalla riqualificazione fisica a quella sociale o economica), i mezzi per operare (come finanziamenti e procedure pubbliche, partenariato pubblico-privato, crownfunding, investimenti etici) e così via. L’alterazione del progetto - in questo caso urbano - da esercizio “collettivo” tipico del secolo scorso a una dimensione contingente e situazionista è, a mio avviso, frutto di questa soggettività, promossa e praticata oggi da molta parte della società italiana ma, per motivi che in questa sede sarebbe improprio approfondire, soprattutto dalla classe politica attuale. In sintesi, quello che caratterizza la società italiana - che sembra confusa - appare essere la sinteticità e l’approssimazione del dialogo, la semplificazione operata sulle sollecitazioni dei cittadini e del Paese, l’accentuarsi della centrifugazione e la diversa ripartizione delle classi sociali. La concentrazione della ricchezza si è enfatizzata negli ultimi anni e non riguarda solo aspetti economici: sempre più spesso, la riconfigurazione delle classi sociali - nella quale, oggi, va categorizzata in particolare quella dei giovani precari che unisce il dato demografico a quello dell’instabilità esistenziale - si manifesta in una divisione tra chi possiede e chi non ha, anche in termini di opportunità, diritti, accesso all’istruzione, alla sanità o altro. Condizioni vitali che determinano stati d’animo sociali - e non solo, anche modi di agire - che influenzano la società civile e creano un’evidente, profonda, frattura tra teoria e pratica nell’affrontare i temi che riguardano il futuro della città.
A fronte di questa soggettività - più correttamente andrebbe utilizzato il termine individualismo - è di particolare significato, nei diversi modi con i quali si manifesta, l’attivazione dei singoli cittadini e delle associazioni in forme di autorganizzazione per contrastare il degrado urbano, territoriale e ambientale. Una nuova attenzione e un allargamento a valori immateriali del concetto di “bene comune” caratterizzano un nuovo e importante approccio dal basso alla rigenerazione urbana, che sembra essere ignorato - talvolta contrastato - dalla politica nazionale. Laddove “periferia” diventa sinonimo di esclusione dai diritti si attiva un meccanismo collaborativo e collettivo per il proprio riscatto e la ricerca di nuovi modi d’innesco alla riabilitazione della città, profondamente diversi da quelli della stagione dei programmi edilizi anticiclici di qualche decennio fa. Esempi che segnalano la ritirata dello Stato come garante del rispetto dei doveri e della certezza dei diritti che consente l’accendersi di episodi d’intolleranza, l’avvenimento di tragedie causate dal degrado a pochi passi dai quartieri “per bene”, l’esistenza di comunità ostaggio di pochi criminali che controllano il territorio e alimentano la strumentalizzazione da parte degli estremismi di destra sempre pronta a cavalcare la paura dei cittadini. Così, PU può essere considerato il grande intervento di rigenerazione urbana, magari a firma di un’archistar, o l’intervento di recupero di edilizia residenziale di lusso, ovvero l’azione di riabilitazione sociale promossa nel quartiere periferico e degradato da associazioni culturali, Onlus e amministrazione locale, magari con il supporto finanziario di Fondazioni bancarie, come sta avvenendo sempre più spesso. In questo modo, tuttavia, si confondono i confini, gli obiettivi, gli elementi costituitivi del PU, lasciando aperta la discussione su quali siano gli elementi che lo possano far considerare tale.
La dialettica sul PU, quindi, dovrebbe essere ricondotta alla statuizione della città come “bene comune”, laddove la qualità del progetto, in senso lato, e della vita urbana viene a essere diretta espressione del capitale sociale e relazionale che la “vive” e ne determina la trasformazione, a volte dovendo rinunciare a un’utilità personale a fronte di quella collettiva. Appare evidente, quindi, che sia necessario intendersi su cosa sia, in un determinato luogo e momento, un PU. Di conseguenza, si pone una domanda cui rispondere, per capire se esista un’utilità o meno del PU: a quali esigenze, fabbisogni, può o deve far fronte il PU, in una situazione di atomizzazione e di tendenziale “egoismo delle comunità”? Anche se può sembrare un paradosso, l’individualismo oggi trova spazio all’interno di una giustificazione collettiva, motivata dalla difesa della propria dimensione fisica e immateriale.
Forse la chiave di lettura per il rilancio del PU è da cercare nel ripristino della dimensione collettiva e collaborativa, facendo riemergere la civiltà, la comunità come soggetto protagonista del proprio destino a grande, media e piccola scala. Il PU diventa utile in proporzione a quanto riesce a stimolare l’intelligenza, la volontà e la collaborazione collettiva, in aperto contrasto con la tendenza attuale di chiusura e di rifiuto di queste dimensioni nella progettazione urbanistica. Da questi aspetti occorrerebbe ripartire per trovare le ragioni, i contenuti e gli obiettivi di un PU rinnovato e utile, in risposta ai fabbisogni sociali che sono emersi a valle del decennio di crisi economica, ancora non superata.
Il PU troverebbe una sua forte utilità qualora (ri)diventasse il luogo della riflessione e della previsione in risposta non solo alla domanda di cittadinanza pregressa - con un deficit ereditato dal secolo scorso di edilizia sociale, servizi socio-assistenziali, qualità eco-sistemica - ma soprattutto per rispondere alle nuove domande della futura società italiana, caratterizzata dall’invecchiamento, dall’inclusione di migranti di terza o quarta generazione, dalla concentrazione della ricchezza e dall’incremento della diseguaglianza sociale. Tuttavia, la linfa per questo rinnovamento non può che avere origine dalla “politica” della città, nel suo significato ampio e in una sua dimensione condivisa dalla società, con obiettivi concreti, visibili e quasi autoevidenti, tali da convincere della bontà di uno sforzo progettuale che investe sul futuro della città, per renderla vivibile alle persone che la abitano.
Seguendo questo percorso, è possibile un riscatto civile del PU, con gesti e iniziative che favoriscano una cultura della città come civiltà dell’abitare insieme. Vorrei citare un recente esempio, che riguarda Palermo. Si tratta di un progetto di riqualificazione di una piazza nel quartiere Sperone, ai margini dell'omonima via nell'area industriale Brancaccio, all’estrema periferia est della città. La piazza è stata ricavata dalla demolizione di una scuola occupata per decenni dalla criminalità organizzata e mai utilizzata come tale, ma segno tangibile della sua presenza nel quartiere. Per iniziativa degli architetti di Palermo, in attesa dell’avvio amministrativo del recupero è stato promosso una call per gli architetti under ’40 al fine di sviluppare un laboratorio, coinvolgere i bambini e re-immaginare quello spazio - desolato, brutto e sporco oggi - con un nuovo asilo nido e uno spazio per la collettività. Nelle giornate di lavoro, oltre ai bambini, sono state coinvolte diverse componenti della città: architetti, professionisti, cittadini, imprenditori, istituzioni. Se in un’altra città questo sarebbe da considerare un episodio comune - non sono poche l’esperienza di progettazione partecipata, a partire dall’ultimo decennio del secolo scorso - in un luogo come Brancaccio questa iniziativa “dal basso” come risposta creativa, entusiasta e collaborativa dei cittadini, soprattutto quelli più piccoli, assume anche un valore di riscatto dell’intera comunità. Adesso spetterà all’amministrazione non deludere le speranze di “rigenerazione” che sono state così chiaramente espresse, per rendere credibile quel piccolo PU.
Q2. Della fattibilità
Non c’è dubbio che la crisi del progetto urbano sia imputabile ai suoi limiti nella concezione e messa in forma delle previsioni d’intervento, oltre che naturalmente alle condizioni più complessive che ne possono pregiudicare la fattibilità economico-finanziaria, amministrativa e sociale.
Così ad esempio la crisi prolungata del mercato immobiliare frena investimenti pubblici e privati troppo complessi e a elevato rischio per i ritorni dei capitali impiegati. I progetti inoltre richiedono una varietà di strumenti giuridico-amministrativi, anche di natura pattizia, per far fronte alla notevole diversità delle situazioni in gioco, e comunque costringono a prendere notevoli responsabilità con decisioni partecipate. Infine, le conflittualità che insorgono in un progetto di maggiore complessità inducono a difficili strategie di costruzione del consenso e di compensazione degli interessi in gioco, che la politica spesso preferisce evitare.
Quali sono a suo avviso le ragioni che più ostacolano oggi il successo dei progetti urbani? È possibile fare qualcosa per rimuovere questi impedimenti?
Vi sono molte ragioni di natura generale che ostacolano i progetti di trasformazione urbana e del territorio e che possono essere riprese, tutte, anche nel caso specifico del PU. In primo luogo, la difficoltà di mettere insieme la volontà decisionale, dovuta alla frammentazione dei luoghi di potere e all’uso strumentale del frazionamento e dell’articolazione istituzionale. Questa frammentazione è temporale, oltre che di allineamento politico: la durata dei governi regionali e comunali, senza il mantenimento d’indirizzi di lungo termine, impedisce di consolidare e mantenere progetti - urbani, infrastrutturali e territoriali - che richiedono molti anni per essere realizzati.
Ci si muove in un continuo dilemma: assodato ormai che non si riescono a ridurre i tempi per la decisione e per l’attuazione di programmi d’investimento urbano e territoriale, l’unica via sarebbe organizzare un nuovo sistema che induca ad adottare scelte di utilità - dimostrata e validata - anche per periodi più lunghi rispetto a quelli di un mandato politico, nazionale o locale, assumendo poi come priorità la conclusione delle opere e degli interventi già previsti. Si dovrebbe, tuttavia, recuperare la sfiducia, ormai palese, circa l’indipendenza della tecnica rispetto al decisore politico, soprattutto quando quest’ultimo è anche il “dante causa” dell’analisi degli scenari economici, finanziari, sociali e ambientali di un progetto. Così, a prescindere dal colore politico, avere una visione di medio-lungo periodo dovrebbe diventare un impegno valoriale, cui far corrispondere azioni continue e orientate, magari flessibili nel tempo. Ma la modalità di intervento descritta contrasta con le regole, gli strumenti, le prassi consolidate fino ad oggi utilizzate nel PU e, più in generale, nella programmazione e nella pianificazione del territorio.
Se non avviene una profonda rivoluzione culturale e istituzionale, il dilemma è destinato a non risolversi, con il permanere delle ragioni profonde dell’incapacità di realizzare progetti urbani significativi. Anche i cambi d’indirizzo a livello nazionale sulla pur debole e ormai episodica politica urbana, impediscono il mantenimento di strategie di lungo termine. Un esempio tra tutti riguarda il Piano Periferie del 2016, interrotto e de-finanziato solo dopo due anni dall’avvio a favore dello sblocco della spesa degli avanzi di gestione da parte dei Comuni non in dissesto finanziario. Un’altra ragione di natura generale è data dalla caduta verticale da parte dello Stato della capacità di analizzare e comprendere l’evoluzione delle dinamiche urbane e, se non prevenire il possibile degrado urbano, almeno agire con un impegno proporzionale ed efficace rispetto alla complessità e alla vastità dei problemi. Sempre per citare il Piano periferie, appare di tutta evidenza la tendenza a replicare modalità competitive tra le autonomie locali, basate - per sintetizzare - sulla “cantierabilità” e quindi, di norma, sul riutilizzo di progetti, più o meno esecutivi, soprattutto di opere pubbliche che non corrispondono più alle esigenze e ai fabbisogni attuali, ma servono solo per collocarsi utilmente in una graduatoria. È lo sconfortante panorama che si osserva palesemente nel caso del “Piano Città” partito circa sei anni fa con grande enfasi anticiclica, oggi sostanzialmente arenato e con l’esigenza di una robusta riprogrammazione. Rimangono aperte tutte le questioni che hanno caratterizzato la seconda metà del Novecento, già all’epoca esasperate a causa dell’introduzione di nuove modalità integrate e complesse di azione sulla città: difficoltà di cooperazione e di collaborazione istituzionale (sempre vittima di visioni opportunistiche e contingenti), criticità nell’impostare un corretto, trasparente e serio partenariato pubblico-privato (molto discusso e annunciato, poco o malamente praticato, foriero di pratiche al limite oppure oltre la legalità), impossibilità di coordinare finanziamenti di diversa provenienza (spesso per imporre, da parte delle istituzioni, una propria autonomia decisionale), avvio di interventi asimmetrici di livello istituzionale (segnale della incapacità di dialogo tra le amministrazioni), mancata inclusione di azioni autorganizzate dai cittadini nei processi di riqualificazione urbana, separazione tra linee di intervento fisico, immateriali e di sostegno al lavoro, all’istruzione, e così via.
Non dimentichiamo che a questi problemi, ormai storici, si è sommata una situazione economica depressa che, in poco più di dieci anni, ha distrutto una buona quota dell’economia italiana. Tra i lasciti di questa crisi, ancora non finita e che si ripresenta con forme sempre più complesse, vi è la mancanza di aggregazione delle potenzialità di investimento in circuiti finanziari a rischio. Di fatto, di tutte le grandi città italiane solo Milano ha la capacità di proporre investimenti attrattivi, di dimensione internazionale e lanciare la propria visione del futuro in una competizione europea. Il resto dell’Italia, tuttavia, non può essere abbandonato; è il campo di azione dove occorre rilanciare, in particolare da parte delle istituzioni, un’opera d’innovazione territoriale ed economica che riguarda le città capoluogo, le città medie, i comuni minori. La crisi ha lasciato anche convincimenti difficili da superare, se non impostando un radicale cambiamento di pensiero e di azione: non ci sono (più) le condizioni del mercato immobiliare tali da consentire l’avvio d’iniziative di valorizzazione del patrimonio, sia pubblico sia privato; i livelli di redditività immobiliare e in generale delle attività economiche non sono (più) tali da rendere appetibile l’investimento da parte dei privati; le risorse pubbliche, abbondanti venti anni fa, sono oggi ridotte ai minimi termini e quindi non è (più) possibile impostare e attuare politiche d’intervento a regia pubblica nelle città; che, soprattutto, manchino competenze e strutture organizzate per gestire la trasformazione urbana; da ultimo, ma forse la convinzione più radicata, che non vi siano (più) strumenti giuridico-amministrativi efficaci. Convincimenti che occorre superare con azioni pragmatiche e concrete, principalmente modificando il nostro modo di pensare, ripristinando una minima fiducia nel futuro, anche tramite la ricostruzione di un’amministrazione pubblica affidabile.
Il cambiamento radicale necessario per far evolvere il PU riguarda soprattutto la rimozione di una serie di convinzioni e di comportamenti: del modo di intendere e praticare nella vita reale la disciplina urbanistica, per rendere concreta la sua azione; della scarsa attenzione da parte dei decisori politici alle questioni urbane, territoriali e ambientali; dell’esigenza di superare un approccio del Novecento nella rigenerazione urbana e ambientale, ricercando un’organicità di azione e adottando una filosofia economica circolare, contributiva e collaborativa.
Tutto questo, a mio avviso, dovrebbe aver luogo rivitalizzando una pluralità di risposte necessarie per operare nell’ambito della città, consolidate nel secolo scorso, ma adattandole alle nuove esigenze attuali della società italiana:
- la complessità del progetto, che riguarda sia l’ampiezza delle tematiche, che l’integrazione delle strutture e dei soggetti decisori, con un’applicazione costante e di lungo termine;
- l’ingegneria amministrativa per costruire un supporto tecnico adeguato alla esigenza di governare la trasformazione in modo integrato e consensuale, con un alto livello di professionalità della PA, che da sempre costituisce la scommessa maggiore per una concreta e seria riforma delle tecnostrutture pubbliche;
- l’interdisciplinarietà, ormai indispensabile a causa della frammentazione delle conoscenze e delle competenze tecniche e umanistiche, che impone un dialogo costante tra discipline diverse e una grande adattabilità alle continue innovazioni;
- il partenariato pubblico-privato, che rappresenta, almeno nelle parole, un metodo ormai consolidato e normato a livello comunitario e nazionale, ma che in realtà non riesce ad essere recepito nella cultura istituzionale italiana e reso esente da patologie collusive e corruttive;
- l’adattabilità dei programmi e dei progetti, che ha come presupposto una guida e un processo organizzato, orientato e continuo, per costruire la rete tra imprese diverse e complementari, proprietà immobiliare e capitale di rischio imprenditoriale, sistema economico e finanziario, potenzialità e ricchezze culturali e ambientali. Molto del successo di progetti complessi urbani è dovuto, infatti, alla qualità del capitale relazionale che condivide una visione futura della città.
Queste risposte si sono formate anche a seguito di un lungo dibattito - spesso anche violento - nato anche dalla contrapposizione tra l’urbanistica tradizionale degli anni ’70-’80 e la stagione delle sperimentazioni dei programmi complessi e integrati, con tutte le sue luci ed ombre. Se riuscissimo, finalmente, a dichiarare acquisiti i risultati positivi di quel periodo storico registrando le profonde innovazioni prodotte in particolare nelle leggi regionali sul governo del territorio, il tema per il futuro sarebbe cosa proporre per una città contemporanea e, di conseguenza, su quali argomenti riflettere per il PU futuro.
Ancora una volta si prospetta l’esigenza di realizzare una politica istituzionale decisa e coerente, che informi le azioni di riqualificazione delle città con una visione organica del territorio, dell’economia, della società, della tutela e valorizzazione ambientale. Per superare gli ostacoli, a mio avviso, sarebbe necessario cambiare radicalmente strada, mettendo in discussione una serie di convincimenti che ci hanno accompagnato per decenni, sul tema della rigenerazione urbana e quindi anche del PU.
Lo schema tipico di strutturazione dei progetti urbani mette in competizione le proposte con i (pochi) finanziamenti da destinare a opere, di norma pubbliche o d’interesse pubblico, con l’idea di dare lo stimolo a programmi (auspicabilmente) organici, composti da azioni materiali e immateriali, in parte cofinanziati da soggetti privati o da una pluralità di finanziamenti pubblici spesso già concessi, che dovrebbero rispondere a quanto richiesto dal bando. In genere, una commissione composta dalle istituzioni e da esperti di settore, fornisce un giudizio e predispone una graduatoria delle proposte da finanziare. Si formalizza il finanziamento, si procede all'esecuzione delle opere e, in genere, non viene "misurato" il risultato effettivo rispetto all'obiettivo. Un metodo consolidato, replicato con diverse varianti ormai da molti anni, ma senza capitalizzare le esperienze precedenti. Ma sono molte le convinzioni da mettere in dubbio, soprattutto in merito alla giusta modalità di allocazione ottimale delle risorse.
La prima è proprio la competizione nell’assegnazione delle risorse. Se questi finanziamenti fossero usati principalmente per stimolare un dialogo cooperativo tra le istituzioni, i soggetti esponenziali, tutte le forme di organizzazione della società e dell'economia del territorio presumibilmente, nel tempo, potrebbero favorire la costruzione della visione futura della città e del territorio; certo, sarebbe necessaria una convinta intelaiatura nazionale di riferimento sulle politiche urbane e su quelle di economia territoriale che, come sappiamo, ancora oggi sono deficitarie ed episodiche. In un periodo d’instabilità come quello presente, la coesione e la cooperazione istituzionale, integrata dalla sussidiarietà orizzontale e verticale sembra essere la vera chiave di successo di qualunque ipotesi di sviluppo su base territoriale.
La seconda certezza da discutere è la stretta connessione tra finanziamenti e realizzazione di opere e lavori pubblici. E se, invece, costruissimo programmi d’intervento sulla città di natura principalmente gestionale, ovvero composti da azioni legate al coinvolgimento del milieu locale, con ritorni di gestione finanziaria e di carattere sociale, di medio - lungo periodo, tali per cui gli interventi di recupero degli edifici siano solo strumentali allo svolgimento di queste azioni, che chiamerei di riqualificazione "umana" e non urbana? Se l'idea fondamentale per superare gli ostacoli che rendono difficile l’attuazione del PU è mettere in moto la società locale, forse il vero riferimento per la rigenerazione urbana a cui riferirsi sono i cittadini, le famiglie e le imprese, con i loro progetti, fabbisogni e programmi e non semplicemente le "mura". Un embrione di quest’approccio era contenuto in alcuni programmi finanziati dalla UE (Urban, Urban Italia e altre generazioni di programmi UE per la città) ma non sembra sia stato perseguito fino in fondo. Anzi, sotto molti aspetti le politiche urbane proposte dalle UE sono state caratterizzate, almeno in Italia, da discontinuità, scarsa efficacia e una grande distanza tra l’enfasi dei documenti e gli impatti reali sui programmi nazionali e regionali; a tacere dell’effettiva capacità di spesa in ambito urbano delle autorità preposte alla gestione dei cofinanziamenti europei, che ha rivelato un vulnus rilevante nella politica e nel sistema tecnocratico italiano proprio sulla rivitalizzazione della città.
Una possibile chiave evolutiva sarebbe adottare un diverso modo di misurare la valutazione della qualità dei risultati del PU, partendo dagli effetti che s’intendono produrre. Uno spunto è fornito dall’introduzione del BES (Benessere equo e sostenibile) nella legge di bilancio del 2016, per la quale gli indicatori BES entrano nel bilancio dello Stato e rendono misurabile la qualità della vita, e valutabile l’effetto delle politiche pubbliche nei temi sociali fondamentali come la salute, l’istruzione e la formazione, il lavoro; inoltre la conciliazione dei tempi di vita, il benessere economico, le relazioni sociali, la politica e le istituzioni, la sicurezza, il benessere soggettivo, il paesaggio e il patrimonio culturale, l’ambiente, la ricerca e innovazione, la qualità dei servizi. Sono tutte dimensioni alle quali i decisori nazionali, regionali e locali dovrebbero rispondere ed essere misurati dai cittadini che ne sono destinatari, i quali sempre meno tendono a essere soggetti passivi, spostando la politica dalla rappresentanza all’autorganizzazione - anche antagonista alle istituzioni - sui problemi reali.
Per onestà intellettuale occorre dire che non potrà essere la generazione del secolo scorso ad operare in modo credibile questo cambiamento, il quale deve mettere in discussione certezze che avevano un significato e un valore nello scenario economico - e di conseguenza urbano - di venti o trenta anni or sono. Dubito anche che i trentenni di oggi siano in grado di riprendere alcuni principi fondanti della nuova civiltà urbana in divenire (come l’equità distributiva, la solidarietà ecologica e ambientale) per rigenerarli con una nuova cultura propensa a sfruttare potenzialità ancora inespresse e inesplorate, utilizzando virtuosamente l’enorme capacità di rete odierna e che sarà sviluppata ancora di più nel futuro.
La prossima partita urbana si giocherà sulla capacità di prevenire discriminazioni e forme di selezione tra le persone perché, verosimilmente, sarà scomparso il modello di welfare universalista del secolo scorso che ha accompagnato l’affermazione dell’equità come fondamento della coesione sociale del mondo civilizzato. La scommessa è sulle generazioni future e quindi vi è una grande responsabilità delle Università e dei luoghi di formazione. Gli urbanisti (potranno ancora essere chiamati così? Dovranno diventare degli “influencer” urbani?) che si stanno formando ora e nei prossimi anni, riusciranno a far parte di un movimento globale che sostituisca le fonti energetiche fossili, modificando radicalmente il modello di consumo? Saranno in grado di gestire i conflitti demografici e sociali che investiranno, quasi certamente, le città europee e quelle italiane? Saranno capaci di mettere mano a un consistente programma di rigenerazione del territorio e dell’ambiente compromesso da decine di anni di comportamenti illegali, superficiali e criminali che hanno danneggiato i tessuti urbani, il paesaggio e l’ecosistema?
Sono capisaldi per la transizione verso il ventiduesimo secolo. Come previsto, verso la fine di questo secolo, forse prima, subiremo un secondo shock energetico, simile a quello dei primi anni ‘70. In questo caso il dramma sarà dovuto all’irreversibilità dei cambiamenti climatici che metteranno in discussione la vita sul pianeta. Si tratta di una sfida che coinvolge il mondo intero, che implica scelte etiche e di sistema, che riguarda anche un modello possibile di democrazia dell’energia, dell’acqua, dell’abitazione, del lavoro, della salute (alle quali dovrebbero poter accedere tutti come sarebbe necessario - e non sempre avviene - per il cibo). Se, ad esempio, oggi alcuni Comuni pugliesi stanno sperimentando il “reddito energetico di cittadinanza” mentre la Regione, di colore politico diverso da quello dei Comuni innovatori, lo ha assunto in una propria legge, il campo di riflessione dell’urbanistica dovrà, probabilmente, essere molto diverso da quello attuale. Se la condizione dell’ambiente e del territorio è tale da far assumere il rischio come una condizione progettuale ex ante, rispetto alle trasformazioni possibili, quasi paradossalmente sembra necessario, per il prossimo secolo, riprendere il pensiero fisiocratico di Francois Quesnay, medico ed economista vissuto nella metà del 1700. Per Quesnay l’agricoltura era la vera base di ogni altra attività economica e, di conseguenza, era necessario porre grande impegno alla “cura della terra”, intesa come elemento di produzione della ricchezza e di alimentazione. Se si affacciano nuove forme di riqualificazione urbana, che favoriscono la collaborazione dal basso, come le cooperative di comunità, se la società diventa sempre più sharing affievolendo il concetto di proprietà, se aumentano i vari e diversi modi di appropriazione - anche ai limiti, se non oltre la legalità - di utilizzo di beni pubblici abbandonati (ovviamente ci si riferisce alle forme virtuose di collettivizzazione delle proprietà pubbliche e non ad sottrazioni illecite) per dare una risposta a fabbisogni non più soddisfatti dalle istituzioni, allora forse occorre ripensare completamente il rapporto tra i cittadini e i luoghi in cui abitano, riproponendo qualcosa nella formazione degli architetti e degli urbanisti che li faccia assomigliare molto di più ad un tecnico condotto, proposto già da Marcello Vittorini molti decenni or sono.
Sono temi che coinvolgeranno la vita nelle grandi città, ma non saranno indifferenti, soprattutto in Italia, ai tessuti cittadini minori, alle città medie e piccole, già fragili oggi e che potrebbero subire in futuro un’ulteriore scollamento dalle reti privilegiate, infrastrutturali, economiche e (bene ancora più prezioso, nel futuro) dalle informazioni e dai servizi immateriali ad alto valore aggiunto.
Q3. Idee per il futuro
EWT ritiene che il rilancio del progetto urbano sia possibile solo a condizione di innovarne profondamente la concezione, i contenuti, e la stessa metodologia di elaborazione. Nelle attuali condizioni di incertezza e di imprevedibilità delle dinamiche urbane, c’è bisogno di progetti processuali, flessibili ed evolutivi, piuttosto che di un disegno rigido e vincolante a medio-lungo termine attraverso cui fissare in modo normativo le forme, gli assetti e le stesse intese pubblico-privato che sostanziano il progetto. La stessa forma del progetto è destinata a cambiare, come convergenza progressiva di una moltitudine di azioni preferibilmente place-based e people-driven, spesso multiscalari ed eterogenee tra loro, ma comunque accomunate dalla coerenza rispetto a una visione di futuro sufficientemente condivisa. Come rendere compatibili gli obiettivi assunti inizialmente (qualità, prestazioni funzionali, equa remuneratività degli investimenti) con i necessari aggiustamenti in corso d’opera diventa il tema centrale del progetto, un tema particolarmente ostico a cui comunque non è possibile sfuggire.
Muovendo dalle esperienze positive fatte per i centri minori, quali sono a suo avviso le innovazioni da apportare al progetto urbano in Italia per migliorarne la efficacia, la fattibilità, e la qualità dei risultati?
Come credo appaia evidente da quanto argomentato, il rilancio del PU è possibile solo modificandone molti degli elementi costituitivi, in particolare utilizzando una maggiore dinamicità di azione, una visione di medio - lungo periodo e un tatticismo a breve termine. La chiave vincente sembra essere la creatività, l’innovazione e lo sperimentalismo, senza paura di sbagliare, ma purtroppo scontando una grave ipoteca: la mancanza di un luogo, di livello nazionale, dove capitalizzare le esperienze virtuose. Cito un esempio, anche se solo in parte attinente all’argomento in discussione. Qualche Comune colpito da fenomeni di abbandono ha lanciato l’idea di vendere case a un euro, con l’impegno di ristrutturazione da parte degli acquirenti, per tentare di ripopolare il paese (per una breve sintesi delle esperienze, si veda l’inchiesta recentemente pubblicata nel “Giornale dell’Architettura”, rivista on line). Ad una prima iniziativa, di scarsa fortuna, promossa da Vittorio Sgarbi a Salemi in Sicilia, se ne sono aggiunte altre, con schemi e modelli di attuazione differenti e diversificati. A fronte di un problema reale e diffuso nei Comuni italiani - che, peraltro, ci accomuna con la Spagna che sta affrontando il tema istituzionalmente a livello regionale - riguardante l’abbandono edilizio, il frazionamento della proprietà a causa del moltiplicarsi di eredi e aventi diritto, si è risposto “inventando” un modello attrattivo che, peraltro, ha avuto un successo mediatico in tutto il mondo. Non tutto è andato bene, ma non a caso il Comune più strutturato, tra quelli che hanno tentato questa strada, è Gangi (nelle Madonie, quinto Comune in Italia per numero di appalti con fondi europei, spesi al 100%) appartenente a una rete di trenta Comuni che hanno creato un ufficio unico degli appalti, finanziandolo anche con contributi dei cittadini. Gran parte del successo è dovuta alla capacità manageriale del sindaco, direttore amministrativo di una grande società alberghiera, che ha saputo mettere insieme gli interessi diversi, coinvolgere i cittadini e farli convergere verso la rinascita della comunità del paese. Ovviamente si tratta d’iniziative che non possono sostituire politiche pubbliche di sostegno al contrasto allo spopolamento come, ad esempio la defiscalizzazione delle attività commerciali in zone montane o in ambiti a bassa densità abitativa; tuttavia rappresentano un segnale positivo da non trascurare.
Se fosse esistito, come anticipavo, un luogo di capitalizzazione delle esperienze, probabilmente si sarebbero analizzati gli esiti e individuati gli elementi di successo, per farli diventare metodo e pratica: il ruolo di regolazione e d’incentivazione giocato dall’amministrazione pubblica per far incontrare la domanda e l’offerta; l’accompagnamento con interventi di riqualificazione dei servizi e delle opere di urbanizzazione, utilizzando ogni opportunità di finanziamento; il supporto e l’incentivazione di attività economiche locali ad alto valore aggiunto; il recupero delle tradizioni e l’implementazione con tecnologie ICT; soprattutto, la creazione di un clima di fiducia e di collaborazione tra i cittadini e i politici che li rappresentano.
Sul tema dello spopolamento dei piccoli Comuni la Spagna sta investendo molto, soprattutto per annullare il digital divide che caratterizza le città, medie e grandi, dai paesi ubicati in territori a bassa densità. Anche in Italia qualcosa si sta proponendo, con leggi specifiche e qualche investimento. Sulle modalità innovative e creative, non immaginabili pochi anni addietro, con le quali è possibile affrontare temi che riguardano la tenuta del territorio, appare interessante l’iniziativa di un gestore di telefonia mobile virtuale che, riconvertendo i ripetitori di tv analogiche abbandonati di grande diffusione sul territorio italiano, ha creato una rete per le aree a bassa densità abitativa (come valli alpine, aree agricole interne), coprendo una domanda trascurata dai gestori tradizionali che non intendono investire qui in nuove infrastrutture. Il gestore, grazie ad un fondo d’investimento americano, ha deciso di investire direttamente per digitalizzare 300 Comuni con meno di 5.000 abitanti, scelti dai cittadini tramite una piattaforma online, con lo scopo dichiarato di contrastare l’abbandono e lo spopolamento di questi Comuni. Il target di mercato, per quest’operatore, è rappresentato dai 118 mila abitanti dispersi nei piccoli Comuni delle aree interne. Ma se un operatore telefonico intuisce che può esistere una domanda disposta a pagare servizi di comunicazione tali da favorire lo spostamento verso luoghi sicuramente più pregiati dal punto di vista della qualità della vita e utilizza per il suo business plan un fabbisogno (il distacco tecnologico tra i cittadini) che in altre epoche sarebbe stato risolto dal decisore pubblico, non è il caso di rimettere in discussione ruoli, obiettivi, modalità, essenza stessa del PU?
Un altro esempio che dovrebbe far riflettere sulla completa revisione dell’approccio pubblico alle tematiche della città è dato da una recente notizia, nella quale si legge che la divisione di architettura di Airbnb, sta lanciando un prodotto abitativo (volutamente non chiamato casa) “sfidando il modo di pensare tradizionale” e creando “un settore completamente nuovo che aiuta le persone a utilizzare spazi inutilizzati, costruendo una community che connette persone attorno al mondo”, come dichiarato da Joe Gebbia, CEO di Samara, la divisione costruzioni della multinazionale. Il “prodotto” la cui origine è basata sulla previsione della progressiva crescita delle città (entro il 2060, secondo le Nazioni Unite, si costruiranno 250 milioni di metri quadri di nuovi edifici, con una concentrazione prossima all’80% della popolazione in ambiti urbani), è finalizzato a intercettare fabbisogni in corso di evoluzione: proprietà condivisa e riduzione al minimo dei costi, tenendo conto che nelle metropoli lo spazio per abitante sarà pochissimo e molto costoso. Quanto quest’approccio abitativo può interferire nella crescita e nell’uso della città, e quali impatti può determinare sugli investimenti strutturali a larga scala della società, come quelli sulla mobilità, sull’istruzione, sulla sanità?
Se questo è lo scenario delle metropoli globali abitate dalla società internazionale descritta da Saskia Sassen, va detto che l’Italia può puntare su un diverso (e di maggiore qualità?) modo di intendere la vita urbana futura, purché si riescano a comprendere per tempo e a governare adeguatamente i fenomeni demografici e sociali dell’avvenire. Se inoltre si riesce a porre rimedio agli errori del passato, che hanno compromesso e devastato il territorio e l’ambiente, creando condizioni di vulnerabilità fisica e sociale dei tessuti antropizzati, si può creare un grande volano di sviluppo economico e finanziario collegato alla green economy. Assunte queste premesse, anche le città medie possono esprimere potenzialità nuove e contribuire a migliorare la qualità del PU nella sua applicazione. Per una lettura sistematica degli elementi che convalidano quest’affermazione, si rimanda a un recente documento ANCI - IFEL “Il potenziale delle città medie nel Sistema Italia” che analizza, in base ai dati ISTAT, il territorio, la popolazione, l’economia, il ranking delle città medie. Il documento entra nel dettaglio, esaminando le singole specificità, come la finanza locale, le infrastrutture, i servizi, il livello di cultura. Il parco progetti raccolto nel documento conferma che i temi portanti di una politica di livello nazionale sulla città (in particolare, ma non solo medie) oltre alla mobilità, sono la sostenibilità e l’ambiente (con l’evoluzione concettuale ed etica della valutazione globale del costo economico e ambientale delle scelte, per l’intero ciclo di vita della trasformazione e il ricircolo dei materiali e un importante programma di ripristino ecologico); la valorizzazione del patrimonio (in particolare pubblico in un’accezione complessiva nella città dell’allocazione di funzioni istituzionali, di fornitura dei servizi e come strumento di reinvestimento nell’economia della città); la rigenerazione urbana (con la definitiva assunzione dell’inscindibilità delle azioni immateriali di sostegno e rivitalizzazione delle funzioni sociali, economiche e culturali con gli interventi edilizi e urbanistici sui contenitori di queste funzioni); l’innovazione digitale e tecnologica per rendere più democratica, accessibile e piacevole la vita nelle città, rendendo possibili scelte localizzative non obbligate, in funzione dei privilegi di alcune conurbazioni o di porzioni di esse, rispetto ad altre parti della città.
Molto di quello che serve, per rigenerare il PU, innovandolo profondamente, è a mio parere semplicemente l’applicazione concreta, reale ed effettiva di alcuni slogan che riecheggiano spesso nei convegni e nei consessi degli specialisti. Il primo slogan riguarda l’esistenza di una governance e un partenariato stabile, articolato e complesso e l’integrazione tra i soggetti istituzionali, che possono garantire condizioni di stabilità e di successo dell’operazione. È necessario comporre dei veri e propri sistemi di governance con un partenariato stabile che veda la presenza, oltre che dell’Amministrazione locale, spesso anche di quelle di livello sovralocale.
Il secondo si riferisce alla qualità dei contesti legislativi e all’adozione di dotazioni finanziarie orientate a fini sociali e ambientali. Tali condizioni consentono di avere una cornice ottimale per la promozione e l’attuazione di programmi di peculiare impatto sulla città, tenendo conto anche del necessario ritorno economico di mercato. Non vi è dubbio, infatti, che un ambiente legislativo e amministrativo certo e organico, differenziabile in base alle esigenze e alle convenienze locali, può rappresentare una chiave di successo del PU. D’altra parte, oltre alla necessaria compartecipazione - o attivazione esclusiva - del capitale privato, appare necessaria una dotazione finanziaria pubblica orientata a coprire i fabbisogni sociali e le esigenze dei cittadini che non possono o non devono seguire esclusivamente logiche di mercato. Infine, occorre l’accompagnamento costante e certo degli interventi materiali con azioni immateriali di promozione della coesione dei cittadini al fine di contrastare contestualmente il degrado fisico e sociale, e di mantenere l’identità degli abitanti, nell’ambito di una indispensabile mixitè delle classi sociali, anche con lo scopo di ricostituire il senso di comunità e di rispetto delle regole che è venuto a mancare nel tempo. E questa è, forse, la sfida più difficile di un buon progetto urbano.