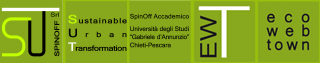Parole chiave: crisi, global/local, democrazia, luogo comune
Abstract:
Per la cultura italiana, il progetto urbano non è una questione come un’altra: il ri-dimensionamento del ruolo che le discipline dell’architettura e dell’urbanistica hanno avuto nella sua “costruzione” produce qualcosa che somiglia alla crisi di un rapporto amoroso. Roland Barthes si è occupato molto del discorso che ruota intorno a questo tipo di rapporto: un discorso comune, ma al tempo stesso vissuto in estrema solitudine e che è possibile pronunciare solo per frammenti. Aderendo alla sua sollecitazione, il testo sceglie due frammenti del discorso sul progetto urbano e prova a inserirli in un nuovo ciclo di vita, considerandoli capaci di intercettare temi urgenti e di essere legittimati da soggetti interessanti.
1. Responsabilità e amore
Non c’è responsabilità senza amore, scriveva Hans Jonas (Jonas, 2002). Chissà se la frase si può ribaltare … forse no … ma, se si potesse, a questa affermazione ribaltata ricondurrei l’attenzione che Ecowebtown dedica alla riflessione sul progetto urbano, oggi. Non c’è amore senza responsabilità. E se la cultura disciplinare italiana vuole testimoniare il suo legame, ancora amoroso, con questi due termini congiunti, deve assumersi delle responsabilità.
Di fronte alla crisi del progetto urbano, che – in termini amorosi – forse più che una crisi è un abbandono (perché il progetto urbano sopravvive, ma spesso proprio tradendo l’architettura e l’urbanistica che l’avevano inventato, e che erano riusciti in alcuni luoghi e per qualche tempo a dominare quella fascinosa ma sfuggente creatura), la cultura disciplinare non deve abbandonarsi al twiddling, alla manipolazione stereotipata e compulsiva della sua ferita d’amore, «come il bambino autistico che osserva le proprie dita che manipolano gli oggetti, invece di guardare gli oggetti» (Barthes, 1979). Ma fare come ha fatto Barthes. Che, parlando del discorso amoroso, (è Pier Vittorio Tondelli a sottolinearlo) si è guardato bene dallo scrivere un manuale “che vi dirà come comportarvi” o “cosa fare per togliervi dall’affanno e dall’ingombro di un abbandono”, e ha provato invece a sostenere quel discorso, costruendo il luogo per affermarlo. Senza nascondersi che quel discorso, parlato da migliaia di individui, è vissuto da ciascuno in estrema solitudine, e quindi non può che essere riprodotto in forma di frammenti; ma anche senza sottovalutare le potenzialità di questi frammenti, che – come nella più aggiornata delle visioni ecologiche – potrebbero essere destinati a nuovi cicli di vita.
Sollecitati dall’appassionato editoriale del suo Direttore, nelle pagine dei numeri precedenti di Ecowebtown dedicate al progetto urbano, i frammenti di discorso non appaiono come brandelli irriconoscibili ma come diffrazioni produttive del récit che la cultura italiana ha costruito intorno al progetto urbano. Un discorso fin dall’inizio complesso, perché l’accostamento delle due parole è sempre andato molto oltre la semplice qualificazione di un sostantivo. E infatti l’espressione “progetto urbano” ha avuto fin dall’inizio significati diversi: non solo dentro l’ampio spazio costruito dall’opposizione architettura/urbanistica, progetto nella città vs progetto per la città ma anche nell’accezione più precisa e al tempo stesso più disciplinarmente ambigua di progetto della città.
Un complemento di specificazione, con una funzione doppia, oggettiva e soggettiva. Per una larga parte della cultura italiana, e per un tempo abbastanza lungo, la città oltre e più che essere oggetto del progetto è il soggetto che lo produce. Il soggetto principale, se non quello esclusivo. E’ la città, e in particolare la città di pietra, che orienta, suggerisce, o addirittura prescrive il proprio progetto. Non è questione di scala, e nemmeno di livelli di intermediazione tra la domanda e la risposta: la città di pietra può accettare di essere modificata, ma secondo le proprie regole e in funzione delle proprie attese, che i progettisti sono chiamati a leggere, interpretare e tradurre nella continuità di una biografia urbana. Una biografia scritta nelle pietre, e nella loro storia,a cui i momentanei abitantipossono contribuire al più con l’aggiunta di qualche memoria.
Tutto bene (si fa per dire, perché i sintomi della perversione erano già evidenti in non pochi di quegli esercizi di traduzione) finché ai due termini – progetto e urbano, il sostantivo e l’aggettivo (spesso sostantivato, e che non a caso traduce la civitas in urbs e in urbanitas) – si poteva attribuire un senso sufficientemente stabile. Finché, cioè, il progetto era dotato di una disciplina e di una legittimazione e l’urbano di un confine e di una struttura. Queste attribuzioni mettevano a posto, ordinavano, da un lato il rapporto del progetto urbano con il potere, dall’altro la sua relazione con le norme, ambedue ancora capaci di essere espressione della civitas, o almeno di una sua maggioranza qualificata (spesso poco interessata a mettere questa qualificazione a servizio di quelli che non avevano voce, ma questo è un altro discorso).
Non mi diffonderò sulle ragioni e sulle forme di questa perdita di stabilità, all’origine della crisi: altri, nei numeri precedenti, le hanno esaurientemente rintracciate e commentate. Aggiungo solo che molti degli agenti di questa crisi coincidono, purtroppo, con i temi più urgenti e con i soggetti più attivi e interessanti della condizione contemporanea. E questo non è un problema da poco.
E allora, visto che mi sento parte del discorso amoroso e che ho accennato alla forma di responsabilità che questo comporta, non posso che mettere in gioco anche la mia estrema solitudine, affermando il valore di alcuni frammenti di discorso: quelli che mi sembrano più capaci di intercettare temi urgenti e di essere legittimati da soggetti interessanti. Insomma, quelli a cui mi sembra utile offrire un nuovo ciclo di vita.
2. Ri-dimensionare1
Quest'operazione
che la costringete sempre a fare
"ridimensionare"
non è come stringere un vestito
non è indolore
si taglia la pelle del cuore.
(Vivian Lamarque)
Ridimensionare. In sé “modificare le dimensioni”, non indica un’azione negativa, … anche se quasi sempre viene usato per parlare di un’azione “in negativo”: ridurre qualcosa a dimensioni più modeste. Portare qualcosa a una dimensione più piccola. Per gli architetti, come per i sarti, ridimensionare è un lavoro come un altro, più di altri praticato in tempo di crisi, legato per definizione a una logica di “cicli e ricicli”.
Ridimensionare: la pratica della crisi. Tra tutte, la crisi della città sembra quella più profonda. Ma la reazione a questa crisi fa pensare alla frase con cui Daniele Del Giudice apre un suo recente racconto: «E’ da quando ho saputo che sarei diventato cieco che ho cominciato ad amare la pittura» (Del Giudice, 2010). Paradossalmente, è proprio di fronte alla crisi della città che il tema della cittadinanza esplode: e alla luce di questa esplosione, il progetto urbano può perdere la sua veste fantasmatica e acquistare centralità e concretezza – sempre di nuovo, anche in una prospettiva post-umana – perfino rispolverando le sue dimenticate propensioni all’utopia o occupandosi invece dell’ordinario. La sua nuova bellezza nasce anche dalla consapevolezza che «lo spazio architettonico è irriducibile alla massa concreta, materica e pesante, perché comprende sia le relazioni tra le masse sia un quid ulteriore: un’eticità sui generis, cioè le condizioni alle quali gli esseri umani possono avere relazioni felici sia con le cose, circostanti e sì tantissime, sia con gli altri esseri umani» (Chiodo, 2011).
Il progetto urbano si è caricato in passato del dolce peso di una relazione con il tema delle identità e delle località. Come ri-dimensionare questo peso senza cedere al rischio di “ridurre” e di ”occultare”? Ridimensionano, riducendo e occultando legami e connessioni” (Remotti, 2008), tutti coloro che puntano al riconoscimento di micro-identità culturali che raramente sfuggono alla tradizionale dimensione del “campanile”; ma riducono e occultano valori e significati anche tutti coloro che appiattiscono l’idea di una identità comune sulla logica di un’identità unica, in nome di una “rete” potente, spesso autorevole nelle premesse culturali ma oggettivamente autoritaria negli effetti economici e sociali: una rete che produce alcuni paesaggi e – magari involontariamente – ne occulta moltissimi altri; inducendo, per esempio, una docile umanità turistica a vivere “pacchetti” di spazio e di tempo a caccia dei patrimoni dell’umanità (Amirante, 2015).
Due sindromi opposte, quella local e quella global, che declinano e deformano il senso delle architetture, delle città, dei paesaggi, in profondità o in estensione. Il progetto urbano è spesso a servizio dell’una o dell’altra di queste reti.
Ma se la ricerca di un’identità dei luoghi dell’urbano non vuole arrendersi alle pratiche di riduzione e occultamento, «ciò di cui abbiamo bisogno sono nuovi modi di pensare, capaci di frequentare particolarità, individualità, stranezze, discontinuità. Contrasti e singolarità, in grado di reagire … a una pluralità di appartenenze e di modi di essere» (Geertz, 1999). E allora, se «ciò di cui manchiamo sono gli accessi che sappiano ricavare, da questi modi di essere, da questa pluralità, il senso di una unione che non è né globale né uniforme, né originaria né costante, ma nondimeno reale» (Geertz, 1999), il progetto urbano sarà in grado di rappresentare uno di questi accessi?
E poi c’è la democrazia. Molti, di questo termine hanno sottolineato la natura e la forza di ideale: non c’è dubbio comunque che questa parola abbia dominato la scena politica della contemporaneità (C. Crouch, 2012). L’irruzione del “comune” su questa scena ha offerto alla democrazia preziose occasioni per misurare il suo impatto sulla realtà, in termini non solo economici ma anche sociali e culturali. E poiché, come ricordava Secchi, non si può non condividere l’opinione di Carl Schmitt, secondo il quale «non esistono idee politiche senza uno spazio cui siano riferibili, né spazi o principi spaziali cui non corrispondano idee politiche» (Secchi, 2013), potremmo chiederci allora cosa fare perché le forme della città contemporanea contribuiscano a favorire l’avvento della democrazia, o almeno a non ostacolarne il cammino. E, forse anche in fatto di spazio, la parola “comune” può aiutarci a ipotizzare una risposta.
Democrazia è una parola complessa che mette in rete molti altri termini: non si tratta solo di “governo” e di “popolo”, si tratta di libertà, di giustizia, di uguaglianza, di diritti e di doveri, di tolleranza (Colombo, 2011) e anche di rispetto per chi non conta, perché magari non è umano o non è ancora nato.
La “nuova questione urbana”, di cui parla Secchi non è estranea al tema della democrazia e investe tutti quelli che si occupano di città di grandi responsabilità: invertire la tendenza alla separazione della città dei ricchi dalla città dei poveri, tenere insieme la spinta verso l’”individualizzazione” e quella verso la “cittadinanza” (Bauman, 2008): per parlare solo di due tra le tante opposizioni che consentono di leggere l’andamento di una realtà sempre più entropica. Che arriva a scuotere le fondamenta di sistemi economici che hanno polarizzato per qualche secolo le sorti del mondo. In questa condizione, il progetto urbano ha una particolare difficoltà a riconoscere e a confrontarsi con le insorgenze, «le potenti espressioni di identità collettiva che si oppongono alla globalizzazione e al cosmopolitismo in difesa delle specificità culturali e del diritto delle persone a esercitare il controllo sulla propria vita e sul proprio ambiente» (Castells, 2003). Anche perché è difficile percepire e identificare i progetti identitari di queste reti di cambiamento sociale, che hanno una natura sottile e decentrata: «Poiché la nostra concezione della storia ci ha abituati a battaglioni ordinati, che sventolano bandiere e agitano proclami di cambiamento sociale, ci troviamo smarriti di fronte alla sottile pervasività dei cambiamenti incrementali prodotti dai simboli elaborati attraverso reti multiformi lontane dai palazzi del potere. Ma è proprio in questi vicoli della società – siano essi reti elettroniche alternative o reti della resistenza comunitaria di base – che ho percepito gli embrioni di una nuova società, coltivata sul terreno della storia dal potere delle identità» (Castells, 2003).
Forse, se vuole tener conto di questi cambiamenti, il progetto urbano dovrà ri-dimensionarsi, potenziando la sua natura di infrastruttura, intesa come “base di sostegno” e non come sistema autonomo e chiuso: un’infrastruttura “teorica”, capace di individuare e di abitare l’amplissimo spazio reticolare intermedio, disposto tra il global e il local, denso di strati e indisponibile a essere sintetizzato in un nuovo termine; e un’infrastruttura materiale, capace di identificare – per farli emergere – gli spazi necessari ad accogliere anche quelle insorgenti comunità reticolari che hanno bisogno e desiderio di abitare la città contemporanea.
3. Luoghi comuni2
Val mica la pena agitarsi,
aspettare basta,
dal momento che tutto deve finire per passarci, nella strada.
Niente da dire. Ci aspetta.
Bisognerà pur scenderci nella strada, decidersi, non uno, non due, non tre di noi, ma tutti.
Stiamo lì davanti a far cerimonie e complimenti, ma capiterà.
Nelle case, niente di buono.
Quando una porta si chiude dietro un uomo,
lui comincia subito a puzzare e tutto quel che si porta dietro puzza anche.
Passa di moda sul posto, corpo e anima. Marcisce.
Se puzzano gli uomini, c’entriamo pure qualcosa. Bisognava occuparsene.
Bisognava farli uscire, espellerli, esporli.
(L. F.Céline)
Luoghi comuni … è difficile immaginare che questa espressione possa essere colta solo nel suo senso originario (il latino locus communis) senza le interferenze del suo significato metaforico, che la schiaccia sull’idea di stereotipo, presto assunto solo nella versione più negativa (comune, trito, banale, e poi anche cliché intriso di pregiudizi, conservatore e perfino reazionario …). Se fosse solo così, quelli che si occupano di architettura non avrebbero molto da dire rispetto a quello che Céline, e poi Gaber, hanno già detto: la strada, la piazza … non saprebbero darsi spiegazioni di alcuni cambiamenti che sono già diventati loci communes, come dicono i giuristi, facendo riferimento a situazioni e a fatti che sono sotto gli occhi di tutti. E soprattutto non sarebbero in grado di prefigurare niente, non sarebbero in grado né di riconoscere, né di inventare (che poi è sempre, in qualche modo, un ri-trovare) le forme dei luoghi comuni della città contemporanea. Una delle cose che tradizionalmente spettano al progetto urbano.
E allora, visto che il significato “secondo”, quello negativo, di questa espressione ha preso il sopravvento, proviamo a scandagliarlo, alla ricerca di qualche via di uscita che, magari, sotto il palinsesto dei significati sovrapposti, ci consenta di intravedere di nuovo, in trasparenza, quello originario; e ci consenta di offrire al luogo comune lo spazio che può e deve occupare per mettere le forme della città contemporanea in tensione verso la democrazia.
Riconoscere e inventare luoghi comuni … “meglio un giorno da leone che una gallina domani”, disse Roberto Benigni ormai molti anni fa, giocando con luoghi comuni proverbiali: l’irruzione del comico sulla scena del comune propone una versione illuminante di un nuovo programma fondato sul riconoscere e inventare … cose note, assonanze, ambiguità, straniamento, assurdo, … tutto, di nuovo, da dimostrare: ma la tensione verso la costruzione di un modo nuovo di produrre il luogo comune resta lì evidente: Benigni lo faceva per farci ridere, ma quanti di noi mescolano pezzi di luoghi comuni consolidati producendo involontariamente piccoli o grandi spostamenti di senso, talvolta illuminanti?
Ma c’è altro e forse di più. I frammenti (noi architetti, potremmo dire gli “elementi”) che compongono il nuovo luogo comune di Benigni sono ancora riconoscibili; e l’effetto de-costruttivo è ampiamente tenuto a bada dalla analogia sintattica.
Difficile trovare nuovi nomi per i nuovi luoghi della città. Siamo ancora fermi ai “viali” e ai “piazzali” con cui le città italiane del dopoguerra hanno provato a rinominare le loro vie e le loro piazze, segnate dall’inedito potere dei flussi infrastrutturali. Per il resto, ci muoviamo in un immenso anonimato: è difficile dare nomi agli informi terrain vagues o agli spazi indefiniti che costeggiano le grandi autostrade urbane, o ancora agli spazi smisurati di molte periferie; e anche a quelli dove gran parte del popolo metropolitano si concentra, in alcune ore del giorno e in alcuni giorni dell’anno. Ma c’è anche il problema opposto: condizionati dai luoghi comuni, continuiamo a dare gli stessi nomi a cose la cui natura è profondamente cambiata. Penso ad alcuni spazi della città “storica” (che solo a volte coincide con quella “antica”): quella che se ne sta dentro tutte le città europee, e in molte altre delle “città del mondo”, come amava chiamarle Giancarlo De Carlo (De Carlo, 2002). Gli spazi della città storica talvolta resistono, conservando quasi intatti la loro forma e il loro senso originario, dentro la città contemporanea; ma più spesso sono stati contaminati, alterati, modificati da trasformazioni parziali, da nuovi usi, da cambi di posizione legati alla perdita della “misura” o della “dimensione” originarie. Hanno smarrito la loro unità, si sono frammentati. Oggi sembrano fatti di pezzetti di storia e di memoria: sono i luoghi dove la “contemporaneità del non contemporaneo” mostra, in piccolo, i suoi effetti concreti. Spesso, in questi spazi, l’opposizione tra brani di monumentalità – che sono conservati come documenti di un passato “qualunque” – e segni spesso violenti della modernizzazione diviene veramente estrema. E per altri versi diventa quasi impossibile classificarli, questi spazi, e persino trovare il loro perimetro, identificare il loro carattere, ridurli a una qualsiasi forma di unità: e diventa difficile anche qualificare concretamente la “domanda pubblica” che potrebbe portare a una loro riabilitazione; benché questa in apparenza sia considerata assolutamente necessaria. Chiamarli con gli stessi nomi è spesso solo un modo per nascondere la loro identità mutata.
L’interrogazione che possiamo porci è la seguente: in questi spazi così contraddittori, è ancora possibile declinare al singolare le parole della descrizione, quelle della classificazione, quelle della figurazione ? E se questo non è possibile, dobbiamo rassegnarci ad abbandonarli al loro destino di materiale informità e di immateriale insignificanza ? O è invece possibile praticare quello spazio dell’opposizione tra gli strati differenti del tempo e tra le parti frammentate dello spazio, accettando delle quote di imprecisione della classificazione, affinando lo sguardo e le tecniche di descrizione, moltiplicando gli sforzi per gestire questa inedita e reale complessità? E il progetto urbano ce la può fare ad accettare questa sfida?
Se si prova a praticare questo spazio, forse ci si può accorgere che nella città contemporanea (reticolare, stratificata, multietnica, al tempo stesso porosa ma densa di recinti, indistinguibile dal suo esterno e piena di margini, attraversata da immensi flussi e segnata da miriadi di interstizi, scomposta in mutevoli centri e periferie) i vecchi luoghi comuni molto spesso esplodono: ma non in mille frammenti colorati e volatili, come nella scena finale di Zabriskie Point, bensì in “pezzi” che, in modi diversi, restano riconoscibili, frammenti di luoghi comuni.
Una deflagrazione di materie e di significati identitari che potrebbe rappresentare una nuova opportunità. I luoghi comuni non sono stabili nel tempo, non è detto che siano riconosciuti da tutti, possono essere identificati da tipi diversi di comunità, come ci ricorda Wikipedia: immesso in un nuovo ciclo, il vecchio luogo comune (quello identitario sì, ma bloccato in un presente incatenato al passato; quello protettivo sì, ma esplicitamente marginato e quindi ineluttabilmente destinato alla marginalità; quello riconoscibile sì, ma il cui volto è una maschera) abitato per ora solo dai frammenti della sua antica unità, può diventare di nuovo, provvisoriamente, uno spazio denso, disponibile a diventare un nuovo luogo comune.
Nuove descrizioni, nuove classificazioni, nuove figurazioni, possono fare in modo che alla perdita della sua unitaria identità corrisponda una moltiplicazione della sua riconoscibilità. Non si tratta di partire da zero: la deflagrazione, l’ho scritto, lascia spesso frammenti riconoscibili; e, come succedeva nel paradossale assemblaggio di pezzi di luoghi comuni che abbiamo ricordato, il loro montaggio può provocare degli slittamenti o delle moltiplicazioni di senso: capaci di rappresentare gli accessi per le tante identità delle comunità reticolari che abitano la città contemporanea.
Il nuovo luogo comune a volte raccoglie l’eredità di una struttura sintattica di un passato che, come diceva Muratori, “sperimentiamo ancora”; a volte ospita elementi topograficamente decontestualizzati, ma topologicamente riconoscibili; a volte è occupato da frammenti ricomponibili in nuove unità, a volte soltanto impregnato da un’atmosfera che propizia nuove attribuzioni di senso. Questi spazi, disancorati dal fermo-immagine che ne ha bloccato l’identità – ancorandola a luoghi comuni che sono diventati stereotipi – e che li ha allontanati dalla vita della città contemporanea, aspettano insomma di essere riconosciuti e inventati: e il sapere dell’architetto non può sottrarsi a questa responsabilità, benché evidentemente non sia più in grado di gestirla in solitudine e quindi non sia autorizzato a soffrire di gelosia. In questa logica, individuare, moltiplicandoli, i luoghi comuni della città contemporanea significa evitare sprechi: sprechi di memorie, sprechi di materie, sprechi di energie individuali e collettive.
Questa nuova “invenzione” forse non è compatibile con gli strumenti tradizionali della pianificazione urbana, ma può realizzarsi all’interno di una nuova virtuosa processualità, di cui la pratica del progetto urbano potrebbe essere il simbolo. Una processualità che richiede soprattutto la capacità di cogliere i cambiamenti in atto, di saperne individuare i caratteri determinanti, e talvolta anche di anticipare coraggiosamente le strumentazioni necessarie per gestirli: credo che anche questa sia tra le cose da fare, perché le forme della città contemporanea contribuiscano a favorire l’avvento della democrazia, o almeno a non ostacolarne il cammino.
Note
1. Per una trattazione più ampia del tema, cfr. R. Amirante (2016).
2. Per una trattazione più ampia del tema, cfr. R. Amirante (2018).
Riferimenti bibliografici
R. Amirante (2015), Historic Urban Landscape, un concetto in costruzione, “Op.cit.”, n. 154.
R. Amirante (2016), Strane bellezze, in R. Amirante, P. Scala, C. Piscopo (a cura di), La bellezza per il rospo, Clean, Napoli, IT.
R. Amirante (2018), Luoghi comuni, in L. Stendardo, Forme della città contemporanea. Frammenti di visioni urbane, Libria, Melfi, IT.
R. Barthes, Frammenti di un discorso amoroso, Einaudi, Torino, IT.
Z. Bauman (2008), Vita liquida, Laterza, Roma-Bari, IT.
M. Castells (2003), Il potere delle identità, Università Bocconi Editore, Milano, IT.
S. Chiodo (2011), Estetica dell’architettura, Carocci, Roma, IT.
G. Colombo (2011), Democrazia, Bollati Boringhieri, Torino, IT.
C. Crouch (2012), Postdemocrazia, Laterza, Roma-Bari, IT.
G. De Carlo (2002), Nelle città del mondo, Marsilio, Venezia, IT.
D. Del Giudice (2010), Nel museo di Reims, Einaudi, Torino, IT.
C. Geertz (1999), Mondo globale, mondi locali, Il Mulino, Bologna, IT.
H. Jonas (2002), Il principio responsabilità, Einaudi, Torino, IT.
F. Remotti (2008), Contro l’identità, Laterza, Roma-Bari, IT..
B. Secchi (2013), La città dei ricchi e la città dei poveri, Laterza, Roma-Bari, IT.