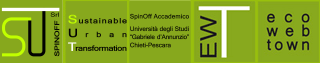Andrea Branzi, in un rilevante articolo sugli architetti razionalisti italiani tra le due guerre, così scrive: “Essi furono grandi, nonostante fossero fascisti militanti, ma proprio perché fascisti militanti. La politica non era per loro una condizione al contorno, ma il Dna dell’architettura. Fu una struttura su cui costruirono interamente il teorema di una modernità diversa, nazionale, razionale e totalitaria, alternativa a quella europea: una modernità basata sull’idea mussoliniana della rivoluzione permanente (di natura futurista), per tracciare uno scenario italico melanconico, pieno di ombre oscure di una impossibilità a vivere nella modernità (di natura metafisica)” (1996).
La politica come il Dna dell’architettura: questo ha fatto grandi i razionalisti italiani ma, vorrei aggiungere, anche la scuola romana dei progettisti della seconda metà del Novecento. In Corviale, ad esempio, furono incarnate la potenza del progetto e il dramma della politica nel loro massimo dispiegamento, ultimo bastione della città del moderno contro la metropoli/periferia che avanzava dentro il massimo della conflittualità sociale. Corviale rappresenta il tentativo fallito di dare un ordine alle trasformazioni sociali, entità etica di una visione della società come comunità politica di individui-cittadini, che andava scomparendo mentre Roma diventava metropoli del consumo totale e proprio per questo e per la prima volta dopo il Risorgimento la vera capitale di questo paese.
D’altra parte, pensare di produrre governo del territorio attraverso un’etica democratica residenziale, -magari come nella Vienna rossa o nella Germania di Martin Wagner-, che potesse mediare i conflitti, denunciava una profonda crisi dell’iniziativa politica-progettuale, non più capace di capire la metropoli che stava nascendo. L’ideologia della città come unità produttiva, come macchina che ripete nei propri meccanismi la realtà dei modi di produzione e della loro organizzazione, stava per essere sostituita dallo sviluppo della ‘città di quarzo’ dove è il controllo su chi vorrebbeconsumare ma non può, e la sicurezza di chi può consumare, a disegnare i conflitti e la nuova struttura urbana.
Il ruolo dell’architetto come organizzatore e collante della struttura urbana sembrava ormai inadeguato e disperso. Quel ruolo che faceva scrivere a Tafuri a proposito della città del moderno: ”La proposta architettonica, il modello urbano che su di essa si articola, le premesse economiche e tecnologiche che essa sottende –proprietà pubblica del suolo e impianti d’industrializzazione edilizia dimensionati sui cicli di produzione programmati nell’ambito urbano- si connettono indissolubilmente fra loro. La scienza architettonica s’integra totalmente nell’ideologia del piano, e le stesse scelte formali non sono che variabili dipendenti da essa” (1969, p.63).
Oggi per tenere insieme una città, al posto della composizione architettonica e della pianificazione, quelle che ancora s’insegnano nelle facoltà di architettura, si teorizzano la paura, l’instabilità, la insicurezza, l’emergenza e allora s’innalzano muri, si installano cancelli, si recintano spazi, si assumono guardie private. Tutto questo non vuol dire che siamo di fronte alla fine del progetto, o che il progetto sia ormai diventato solo business sottomesso ai profitti del primo ‘palazzinaro’ che lo finanzia.
E seppure Rem Koolhaas afferma che l’accelerazione delle cose fa sì “che qualsiasi azione abbia la pretesa di dare una regola allo sviluppo urbano in base a criteri estetici, sociali o etici, é destinata al fallimento. Non vi sono attività di composizione formale né velleità di composizione urbana in grado di reggere una simile accelerazione dei fenomeni, il rapido succedersi di cambiamenti in tempi tanto brevi” (2003, p.38). Questa é solo la realtà sociale che il progetto oggi si trova davanti.
E allora alla domanda: se in una società di mercato é il consumo a produrre relazioni sociali, e se è proprio la coincidenza tra società e consumo a rendere endemico il conflitto, e se, infine, lo spazio pubblico della città contemporanea prende forma e senso, e cioè la sua indeterminatezza e la sua contingenza, nel momento in cui il consumo e il conflitto stessi lo attraversano, come può l’idea di progetto produrre politica e misura del territorio? Non si può che rispondere: costituendosi come controparte politica della realtà del mercato e assumendo le culture del consumo come riferimento imprescindibile, tenendo conto che è proprio da questa carenza di ordine, da queste energie ‘negative’ che hanno fatto della metropoli, fin dalla sua nascita, la scena dove quotidianamente si rappresenta la crisi del progetto, che l’istanza stessa del progetto e della sua rappresentazione ha origine e si costituisce.
Il progetto deve dunque tornare a fare teoria, teoria di parte che produca contesti materialmente determinati e stravolga ogni codice universale che tiene in equilibrio lo spazio omogeneo e senza confini del mercato.
Assumersi il ruolo di controparte vuol dire innanzitutto indicare chiaramente l’avversario: e se l’avversario dichiarato del progetto è la realtà così come è, allora le va dato un nome perché nella metropoli contemporanea le realtà sono tante quanti sono i fenomeni urbani. Ma c’è una realtà che fa da contenitore a tutte le altre, ed è il mercato, l’universalismo del mercato. E, dunque, il progetto è politico proprio perché si concentra alla fine su un luogo specifico e circoscritto, e non si disperde su tutto il territorio. In altre parole, produce un contesto materialmente determinato, traccia confini e provoca differenze nell’uniformità dello spazio globale del mercato. Solo così può produrre un fenomeno rilevante e concreto.
Il progetto, pur nella sua autonomia, non può non definire infatti il suo percorso dentro il ‘politico’ metropolitano, che è violenza, disordine, sconnessione. Non siamo più nella città del moderno dove l’ordine dei discorsi costruiva le relazioni sociali. Oggi l’ordine è difficile perché il conflitto è costitutivo dell’esperienza metropolitana ed è irrisolvibile. Il progetto, dunque, non può essere un dispositivo creato dalla ragione una volta per tutte, ma un processo che ha in sé costitutivamente il concreto non razionale e, di conseguenza, la possibilità sempre presente della distruzione delle sue premesse e del suo fondamento.
Se è pur vero, come affermava Tafuri, che non ci può essere un’architettura di parte, è altrettanto vero che si può fare una critica di parte dell’architettura. Una critica forte, che riconsideri le realtà contingenti e per nulla universali che si celano dietro categorie unificanti quali quelle della città, dell’arte o dell’architettura stessa; e che, soprattutto, demistifichi quella ideologia urbanistica e architettonica che tende a dissimulare, cercando di risolverli in immagini polivalenti, i dissidi insanabili che attraversano il territorio. La forma deve essere invece al servizio della complessità del progetto e non puro ornamento per lo sguardo estetico.
Dunque, nessuna congiunzione di opposti, nessuna risoluzione del conflitto, nessuna dialettica che porti al suo annullamento, ma il progetto come istanza di una dimensione specificatamente politica, una sorta di invito all’azione che, pur dentro il mercato, si ponga fuori dai processi di standardizzazione vigenti, da quelle architetture neutre e diafane, da quei piani regolatori metafisici costruiti dal potere economico. Possibilitàdi ordine più che sua fondazione. Se si rimane nell’apologia del disordine, se si fa della bellezza del caos una specie di bandiera o uno stile, ciò che ne verrà fuori sarà solo tanto romanticismo ma poca architettura.
L’interlocutore diretto del progetto è allora il livello del potere. E anche se legato al suo contesto sociale non si deve confondere con la ‘questione sociale’. L’architetto non é il filosofo che suggerisce un’altra visione del mondo, né è l’ideologo del sociale, anche se la sua architettura ha efficacia rispetto ai rapporti sociali. Il progetto, infatti, deve fare del sociale “un corpo artificiale analizzabile [...], egli é dunque la forza che progetta e ri-progetta costantemente l’artificialità della societas” (Cacciari 1981). Lo stesso progetto della conservazione del centro storico, ad esempio, è politico, e non etico o estetico, perché é l’unico purtroppo, qui in Italia, ad aver prodotto una decisione sulla città storica.
La questione, dunque, è tutta politica: investe direttamente il rapporto tra governanti e governati. La stessa crisi della rappresentanza costringe oggi il progetto a questa sfida, e cioè a produrre decisione politica sul territorio e dentro le sue opposizioni reali: tra forme di rappresentabilità e disordine sociale, dimensione collettiva e anarchia architettonica, diritto al lavoro e diritto al consumo, agire nella rete e vivere sulla strada, città senza luoghi e quartieri blindati.
Occorre allora spazzare via due idee inutilmente angosciose. La prima è che il destino di una società di mercato sia estranea al progetto: la sua ideologia è tanto essenziale all’integrazione del capitalismo moderno in tutte le strutture e sovrastrutture dell’esistenza umana, quanto lo è l’illusione di potersi opporre con gli strumenti di una progettazione diversa o di un’antiprogettazione radicale; la seconda è che tra ordine e disordine non ci possa essere mediazione. L’ordine è difficile perché il conflitto sul consumo e la domanda di libertà, che non richiede partecipazione ma assenza di impedimenti, sono costitutivi dell’esperienza metropolitana. Un progetto che è piantato nel mondo, tiene conto nella sua ricerca delle tensioni che lo attraversano, persegue obiettivi contingenti, produce misura e forma del territorio e può intraprendere questa mediazione.
Il consumo, la libertà, la decisione: da qui, da queste antitesi sembra prendere forma il progetto che, però, a differenza di prima, non ha più tradizioni, storia, identità, memorie cui far riferimento perché, non fosse altro, la città è stata distrutta. E, d’altra parte, un progetto nato dal e nel conflitto non ha macerie del passato verso cui rivolgersi: può vivere solo al presente, finché si oppone al disordine e, insieme, mette in crisi l’ordine consolidato.
Riferimenti bibliografici
Branzi A.,1996, Terragni creò il national style, “l’Unità”, 26.7.
Cacciari M., 1981, Progetto, “Laboratorio Politico”, 2
Koolhaas R., 2003, Archittetura della tabula rasa. Due conversazioni con Rem Koolhaas, Electa, Milano
Tafuri M., 1969, Per una critica dell’ideologia architettonica, “Contropiano”, n.1